Appuntamento fisso con la rubrica Gli incipit dei libri. Oggi tocca a Benevolenza cosmica (Adelphi editore) di Fabio Bacà …. Oltre alla mia recensione (che trovate qui) ve ne ho parlato anche dopo la presentazione svoltasi a Una marina di libri di Palermo, dove ho avuto il piacere di incontrare l’autore e scambiare due chiacchiere con lui.
Il dottor Halliwell m’indicò la sedia congedando con un cenno la segretaria, in piedi accanto alla scrivania. Lei alzò appena gli occhi nella mia direzione, prese un faldone di documenti e uscì dallo studio. La guardai dirigersi alla porta con il passo rapido e l’andatura un po’ marziale di una fanatica dell’archiviazione. Era una ragazza magra, esangue, etnicamente indecifrabile. In sala d’aspetto la sua gestualità sembrava rispettare alla lettera le procedure sindacali dello sciopero bianco: era solerte, dettagliata, sistematica fino all’eccesso. Seduto sulle poltroncine di velluto, l’avevo osservata cercando di immaginarla mentre si sfilava le mutandine sul letto del suo appartamento con la stessa attenzione che poneva nell’ordinare cartelle o firmare impegnative, ma le mie fantasie erano quasi sempre fiaccate dal desolante antierotismo della sua espressione e dalle camicette di cotone abbottonate fino al collo. Mi abbandonai sullo schienale. Il dottore mi squadrò a lungo in silenzio. Ricambiai il suo sguardo, senza forzare l’inizio di una comunicazione produttiva. Cercavo di non attribuire significati particolari al prolungarsi di quell’ispezione: era solo la sospensione ponderata e vagamente teatrale di un professionista devoto ai piaceri dei preliminari. Mi mossi sulla sedia, cercando di simulare un ragionevole livello di preoccupazione. «Ho due notizie per te » disse. Alle sue spalle era appesa una laurea in medicina vecchia di trentanove anni. Sul muro alla mia destra spiccavano due stampe carcerarie di Piranesi; a sinistra, il dipinto vagamente infantile di una nave che solcava un oceano inquieto. Tre cornici su quattro erano di bambù. «La prima è che ci sono altre due minuscole macchie nell’occhio sinistro» disse Halliwell. «Piccole eclissi tra coroide e corpo ciliare, larghe poco meno di un decimo di millimetro». «Piccole eclissi» ripetei. Lui fece di sì con la testa, grattandosi un angolo della bocca senza smettere di fissarmi. Halliwell era il mio medico personale da cinque anni. Durante tutto questo tempo aveva opposto al riserbo da me esibito sugli aspetti fondamentali della mia vita privata un ostinato libertinaggio espressivo su ogni dettaglio della sua. Si era sposato quattro volte e aveva sempre divorziato: da ognuna delle mogli aveva avuto due figli, seguendo un oscuro modello archetipico di compiutezza familiare alla cui realizzazione faceva immancabilmente seguito un rapido declino del suo interesse di padre e marito esclusivo – come se l’idea di un solo nucleo di parenti fosse inconciliabile con i suoi princìpi di fondamentalismo poligamico. Invecchiando aveva raggiunto un’insperata pacificazione sentimentale, grazie alla quale era diventato un placido sessantacinquenne che intratteneva una solida relazione con una professoressa di immunologia della stessa università in cui insegnava da trent’anni. Aveva i lineamenti arrotondati di un amante di birre scure e occhi di un azzurro un po’ losco. Le competenze cliniche e un notevole estro comunicativo avevano contribuito alla sua inarrestabile ascesa nel circolo dei migliori medici di Londra, trasformandolo in una di quelle figure leggendarie che non si fanno scrupolo di concedersi, proprio in virtù del fascino che emanano, una smisurata dose di sincerità. Si allungò sulla scrivania e prese una cartella da cui estrasse due fogli. Me ne piazzò uno davanti e prese una penna dal taschino. «Questo è il referto dell’angiografia coroideale» disse. «Le macchie sono tre in tutto, come vedi ». Con la punta della penna indicò una zona a un paio di centimetri dalla pupilla. «Di solito questo tipo di lesioni intraoculari è sintomatico di una forma di tumore molto rara » disse. «Nel novantasei per cento dei casi maligno». Posò la penna e mi guardò attentamente. «Ma tu sei incluso nel quattro che rimane » disse. Sorrise, in attesa di una mia reazione. Io non mossi un muscolo, ancora atterrito dal breve, terribile attimo in cui mi ero ritrovato a sperare il contrario. «Le analisi hanno praticamente fugato ogni dubbio» aggiunse lui. «Ma vorrei sentire un secondo parere. Ho già chiamato Archibald Rooney. È un oftalmologo di fama, il primo in Europa a produrre pubblicazioni sui tumori del nervo ottico da radiazioni elettromagnetiche. Se non hai impegni, ti riceve stasera». Mi grattai un sopracciglio. «È proprio necessario? » dissi. «Lo sai che ho la massima fiducia in te ».
Halliwell allargò le braccia. «E io ne sono lusingato. Ma in questo genere di cose ho i miei limiti, e preferisco non verificarli sulla pelle altrui». Tirò fuori il cellulare dalla tasca del camice, trovò il numero del suo collega, lo scrisse su un biglietto e me lo consegnò. «Chiamalo a pranzo e digli di tenermi informato. Ora levati dai piedi. Ho un console o qualcosa del genere che mi aspetta all’ambasciata svedese ». Uscendo diedi un’occhiata alla segretaria, impegnata al computer. Accanto alla scrivania c’era un uomo biondo in livrea, quasi certamente l’autista del console. Era giovane e piuttosto attraente. Cercai di immaginarli sul lettino della piscina di un hotel – lui che le accarezzava i piedi, fremente di lascivia scandinava, e lei che lo lasciava fare, soddisfatta dalla rigorosa gradualità della seduzione –, ma il buon esito delle mie fantasie fu di nuovo compromesso dalla camicetta abbottonata e dall’espressione inerte della protagonista. In strada m’infilai nel primo bar. Il cellulare mi vibrò nella tasca interna della giacca proprio mentre raggiungevo il bancone. Era la mia segretaria. «Wendy Smith» dissi. «Kurt, dove sei? Wayne ti ha chiamato tre volte nell’ultima mezz’ora. Dice che hai il telefono spento e che non era mai successo a memoria d’uomo». «Non era spento. Ho qualche problema di segnale». «È passata in ufficio anche tua moglie. Ti richiamerà». «Tra lei e Wayne chi dei due ti è sembrato più isterico?». «Wayne, senza dubbio». «Lo chiamo tra un po’ ».
Mi sedetti su uno sgabello girevole, accanto a una ragazza che indossava una salopette da muratore spruzzata di vernice. Il barista leggeva l’etichetta di uno sciroppo e non si accorse di me per almeno due minuti. Mi diedi un’occhiata intorno. Il bar era uno dei tanti posti di Kilburn sorti a uso e consumo degli studenti universitari: l’arredamento metallico e fluorescente in voga nell’ultimo decennio, due tavoli da biliardo, foto in bianco e nero di strade metropolitane alle pareti. Accanto all’entrata c’erano dozzine di annunci appesi a una lavagna di sughero. La ragazza in salopette fece un quarto di giro sullo sgabello e puntò il viso sul mio profilo sinistro. «Ciao» mi disse. Risposi alzando una mano. «Sei uno studente dell’UCL? » chiese. «No» dissi. « I bei tempi sono finiti ». «In che senso?». «Nel senso che ho un lavoro». «Un lavoro? E sarebbe?». «Hai presente quando qualcuno ti paga per fare qualcosa che desidera venga fatto ma del quale, per qualche motivo, non può occuparsi personalmente?». «Che lavoro è, intendevo». Mi allentai il nodo della cravatta. «Una cosa talmente noiosa che non vale nemmeno la pena che tenti di spiegartela ». «Sei straniero? Hai l’accento straniero». «Non ho nessun accento. Ma un po’ di sangue italiano». «Lo sapevo che eri italiano. Hai il profilo di uno di quei gladiatori costretti a morire per l’imperatore negli anfiteatri di Roma ». « I gladiatori non erano romani. Erano prigionieri di guerra o schiavi delle colonie». «E tu come lo sai?». «L’ho letto chissà dove». «Io mi chiamo Marcelene ». Mi girai a guardarla. Aveva i capelli biondi attorcigliati a una matita rossa da cantiere, grazioso contrappunto alla salopette inzaccherata. Il suo era un viso puntigliosamente inespressivo. Mi bastò fissarlo per dissolvere ogni impulso sadico dentro di me. Nel frattempo il barista mi aveva piazzato davanti un sottobicchiere. «Cosa prendi, bello?». «Un Bowmore. Liscio». «Un Bowmore? Che roba è? ». «Dammi una Tennent’s. In lattina ». «Tu come ti chiami? » disse la ragazza. Il telefono vibrò di nuovo. «Scusami » dissi. Presi il cellulare dalla tasca e mi girai sullo sgabello. «Wayne Merrill» dissi. «Amico mio» sussurrò lui. Da quando lo avevo messo al corrente dei risultati di una ricerca secondo cui un tono pacato incrementava l’autorevolezza dell’oratore di quasi il trenta per cento, parlava sempre a voce bassa. Aveva un complesso irrisolto nei confronti della propria autorevolezza. «La tua segretaria mi ha detto che sei in giro per Londra. L’hai addestrata bene: non sono riuscito a cavarle altro. Dove sei? ». « In un bar di Cambridge Avenue ». «A fare che?». «Avevo un appuntamento all’Istituto di ricerca per le malattie tropicali altamente infettive qui dietro. Il dottor Livingstone dice che l’infezione dovrebbe passare nel giro di un mese. Fino a quel momento sono ufficialmente in quarantena: lui stesso mi ha visitato da un’altra stanza, auscultandomi tramite interfono».
( Qui la mia recensione )

Benevolenza cosmica

La trama
A Kurt O'Reilly non ne va bene una. Ma una, eh? Il medico cui si rivolge per un piccolo fastidio gli spiega, esterrefatto, che in tutti i casi conosciuti quel problema ha un esito nefasto – tranne che nel suo. Sul lettino di un tatuatore, una sensazionale pornostar gli lascia intravedere un paradiso a portata di mano. I soldi investiti distrattamente non fanno che moltiplicarsi. Persino il tassista che lo scorrazza in una Londra appena spostata nel futuro insiste per pagargli lui la corsa. No, decisamente qualcuno trama alle sue spalle, e a Kurt non resta che tentare di capire chi, e perché. Un po' alla volta una macchinazione verrà fuori, in effetti, ma non possiamo dire altro: perché la macchinazione è questo singolare, trascinante, divertentissimo romanzo.











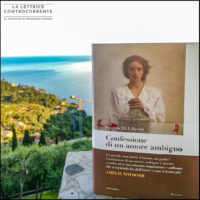

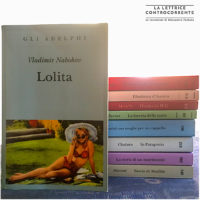
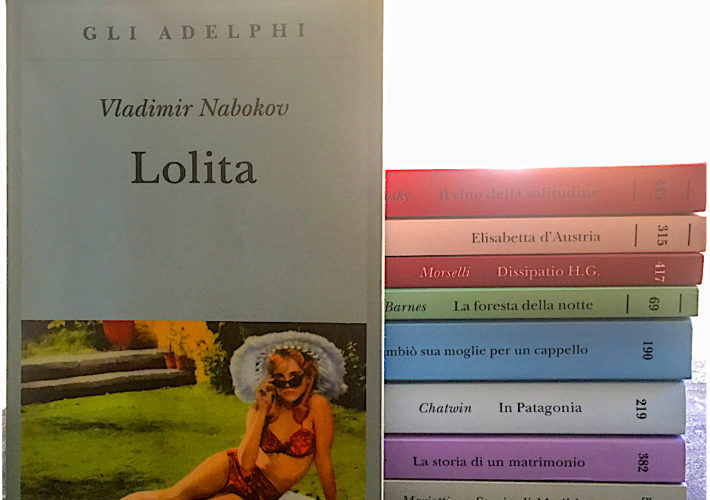


Lascia un commento