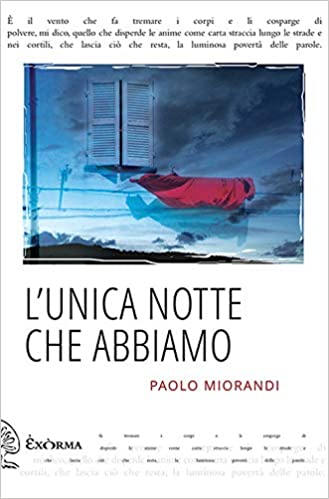
L'unica notte che abbiamo

La trama
Di notte, un uomo alla finestra. Ascolta voci che tornano da oltre il buio. Sono quelle che un'anziana signora, poco prima di tramutarsi anche lei in pulviscolo di parole, ha consegnato all'uomo che ne diventa il custode. Perché ogni essere umano - è questo che l'uomo si dice - prima o poi è chiamato a prendere in consegna la voce di un altro essere umano, e ogni vita è chiamata a offrire la propria voce, per quanto flebile essa sia, a un'altra vita. Le parole giungono come relitti su una costa solitaria. Sono i morti che parlano, ma non tra di loro e nemmeno con i vivi. Monologano, chiusi ognuno nella bolla del proprio ricordo. Ripetono il frammento di storia in cui tutta la loro esistenza è contenuta, come un pianeta che un'indicibile forza di gravitazione ha fatto collassare su sé stesso e trasformato in un unico minuscolo grumo di materia. Ognuno torna sul luogo della propria ferita e la esibisce come per chiedere perdono. L'anziana signora ripercorre le vicende della sua famiglia che nessuno ha mai voluto né raccontare né ascoltare. Cerca tra le mura di un paese senza vita la ragazza che ha abbandonato il figlio, suo padre, poco dopo averlo messo al mondo. Rivede la maestra, a cui il bambino è stato affidato, impegnata nella sua estenuante interrogazione di fronte al silenzio di Dio e di un corpo incapace di dichiarare il suo bisogno d'amore. Ripercorre la via dei campi con la nonna materna, per lunghi periodi suo unico sostegno affettivo. Rivive il rapporto conflittuale con il padre, un sagace perdigiorno di paese, intimamente e indelebilmente ferito dalla tragica esperienza della ritirata di Russia, che ha eletto i bar a proprio dimora. Quella dell'anziana signora è una deposizione che non risparmia le accuse, ma che allo stesso tempo va in cerca di prove per una possibile assoluzione dei protagonisti. È anche una deposizione di corpi sofferenti e mortali, spogliati via via dei propri sintomi, gettati ai margini del tempo e divenuti sacri proprio in ragione della loro inermità.
– Solitudine –
L’unica notte che abbiamo di Paolo Miorandi (Exorma) è un libro spiazzante, malinconico, duro. L’unica notte che abbiamo è una lunga maratona composta da diversi personaggi. Personaggi che si passano un testimone, a volte scomodo, quasi sempre doloroso.
 Quando Exorma mi ha proposto la lettura del libro ho detto subito di sì: storie di famiglia, ricordi sepolti, malinconia… eppure mi sono trovata di fronte a un libro imprevedibile. Miorandi dà voce a personaggi diversi senza introdurli, il passaggio da una voce all’altra, e quindi da una storia all’altra, è continuo e senza annunci. Ogni volta un registro diverso e una vicenda differente da narrare.
Quando Exorma mi ha proposto la lettura del libro ho detto subito di sì: storie di famiglia, ricordi sepolti, malinconia… eppure mi sono trovata di fronte a un libro imprevedibile. Miorandi dà voce a personaggi diversi senza introdurli, il passaggio da una voce all’altra, e quindi da una storia all’altra, è continuo e senza annunci. Ogni volta un registro diverso e una vicenda differente da narrare.
Gli elementi all’apparenza sono semplici: c’è una signora anziana che si sta consumando, una valigia piena di ricordi trasformati in fotografie e tante voci senza lieto fine. Proprio come nella vita.
Quando L’unica notte che abbiamo si apre la vecchia protagonista sta ricostruendo la propria storia di famiglia grazie a fotografie e documenti ritrovati in una valigia che era rimasta nel dimenticatoio per almeno venticinque anni. E ora, di fronte a uno sconosciuto vicino di casa, è arrivato il momento del regolamento di conti. Perché alla fine guardarsi dentro e ricostruire il proprio albero genealogico, fatto di bugie, segreti e a volte violenze, è un atto di coraggio.
Per l’intera vita adulta ho cercato di guardare solamente avanti, di fare come se dietro di me non ci fosse stato nulla, solo adesso, attraverso le mie ricerche storiche, ho deciso di prendere atto dell’eredità che in gran parte mi ha costituito e venendo al mondo mi è toccata in sorte e penso di averlo potuto fare, di aver potuto guardare in faccia la mia storia intendo dire, nel momento in cui ho finalmente accettato che il mio compito non doveva essere né quello di un chirurgo chiamato ad asportare la parte del corpo intaccata dalla malattia né quello del giudice che al termine dell’udienza deve emettere il proprio verdetto, ma semplicemente quello di un passeggero che, dopo aver girato il mondo in lungo e in largo, decide di aprire la valigia chiusa che per tutto il tempo si è trascinato dietro.
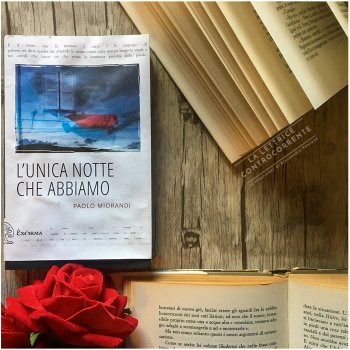 La storia parte da lontano, c’è una ragazza che va a lavorare in un albergo del Trentino, dopo essere fuggita da una situazione di violenza e sofferenza a casa. In quell’albergo verrà violentata dal padrone. Da questa relazione nasceranno due bambini che la donna sarà costretta, per questioni di sopravvivenza, ad abbandonare.
La storia parte da lontano, c’è una ragazza che va a lavorare in un albergo del Trentino, dopo essere fuggita da una situazione di violenza e sofferenza a casa. In quell’albergo verrà violentata dal padrone. Da questa relazione nasceranno due bambini che la donna sarà costretta, per questioni di sopravvivenza, ad abbandonare.
Questi due bambini, Ernesto e Gioacchino, verranno cresciuti dalle insegnanti Maria Martini e Rabensteiner, due donne che vivevano nella stessa casa.
Se per Gioacchino è impossibile provare empatia: è ossessionato dal sesso, è disonesto e… insopportabile, non si può dire lo stesso di Ernesto. Le pagine in cui si trova in Russia sono piene di orrore, crude e potenti:
Siamo spettri che camminano nell’oscurità, guardaci, i nostri corpi sono diventati un grumo di materia che si sfalda ogni passo, di carne marcia a stento tenuta insieme dalla fatica, la sentiamo avvinghiarci i piedi che affondano nel fango e strisciarci su lungo le gambe coperte di stracci e merda, cerco di muoverle scalciando l’aria per far smettere il dolore, per liberarmi dai vermi viscidi che mi si sono attaccati alla pelle che mi entrano nella poca carne che ancora mi resta, non ho più denti né occhi, solo un buco sanguinolento dove c’era la bocca, due croste secche al posto degli occhi, chi è e là?
Ne L’unica notte che abbiamo però, nessun personaggio si salva davvero. Nemmeno Ernesto è una figura positiva, anzi. Non lo è nemmeno Georgette, moglie di Gioacchino e non lo è nemmeno la nostra protagonista. Eppure, hanno tutti in comune qualcosa: la vulnerabilità:
Ci sono notti in cui ci si sente indifesi, forse è il peso del cielo che grava sulla testa, forse è il disfarsi del tempo; non so che ore sono, uno di questi giorni dovrò sostituire le pile della sveglia che ho vicino al letto; cammino senza fretta verso la camera bianca, mi chiedo cosa mi spinga a farlo; in piedi davanti alla finestra mi chino a raccogliere le parole che l’onda ha trascinato fin qui come relitti su una costa solitaria, domande mute provenienti da altre sponde, immagino di infilarle in una vecchia borsa di tela, la stessa dove tengo i vuoti da mettere nell’apposito contenitore per il vetro.
L’unica notte che abbiamo è…
Solitudine. La solitudine di questi personaggi è disarmante. Tutti vogliono qualcosa che non possono avere: c’è chi sogna una carriera di artista, chi scopre di aver sposato una donna depressa, chi è costretto a morire solo in un letto, chi è stato troppo duro… è un’opera corale carica di errori, rimpianti e sofferenze.
L’unica notte che abbiamo è un libro scritto in maniera ineccepibile però, sono sincera, ho fatto molta fatica a tenere il filo della narrazione. Non essendoci introduzioni, stacchi, o chiarimenti sul chi parli, la lettura diventa inevitabilmente faticosa. Una sfida che probabilmente in un periodo di tranquillità avrei accolto con entusiasmo, ma purtroppo se mi seguite da un po’ sapete che nelle ultime settimane sto leggendo poco e con grande sforzo di concentrazione. Resta il fatto che alcuni passaggi sono davvero meravigliosi, inutile dire che quello sul bar mi ha toccato molto e si riaggancia alla parola “solitudine”:
Quando si diventa frequentatori abituali di un bar, quando un bar è stato scelto come propria dimora, si riceve infatti la cittadinanza di una nazione che è allo stesso tempo il proprio paese d’appartenenza e la propria terra d’esilio e, in quanto cittadini di questa particolare nazione, si viene riconosciuti dagli altri avventori – sei uno dei nostri, ti dicono con un cenno del capo quando alla tua ora entri nel bar -, ma tale riconoscimento non implica doveri e non genera attese negli altri frequentatori del bar, né tentativi di modificare il tuo modo d’essere, nei bar ti accettano per quello che sei, un rifugiato, un esiliato che come loro ha trovato la sua patria. Perché nei bar puoi essere loquace oppure non spiccicare una parola, stare al centro dell’attenzione o seminascosto in un angolo, nei bar va comunque bene come sei, nella mutevolezza degli umori, nella provvisorietà che ci contraddistingue, perché quella nei bar è una presenza dalla quale ci si può ritirare in ogni momento, anche a metà di una frase, senza fornire giustificazioni, senza che nessun storca il naso o si sorprenda, ci si può ritirare facendo semplicemente segno al cameriere ed estraendo il portafogli dalla tasca interna della giacca, perché ognuno sa che nei bar tutto è provvisorio, che tutto è appeso a un filo, è da un po’ che non si fa più vedere, diranno dopo qualche giorno e andranno avanti con le loro chiacchiere dimenticandosi subito di te, o tuttalpiù faranno un brindisi rivolgendo il bicchiere verso il tavolino vuoto all’angolo della piazzetta…
Consigliato per chi è in cerca di una lettura forte, toccante e che richiede un certo sforzo, sforzo che verrà ripagato con la bellezza di certi passaggi.





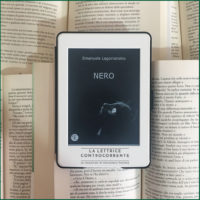






1 COMMENTO
Bruno Timpanaro
1 anno faÈ un vero peccato che il libro vari errori grammaticali e/o di battitura (parole ripetute, “c’è” al posto di “ce”, … ).
Certamente il correttore di bozze non ha fatto un buon lavoro.